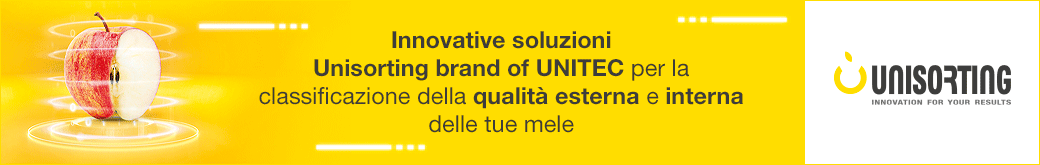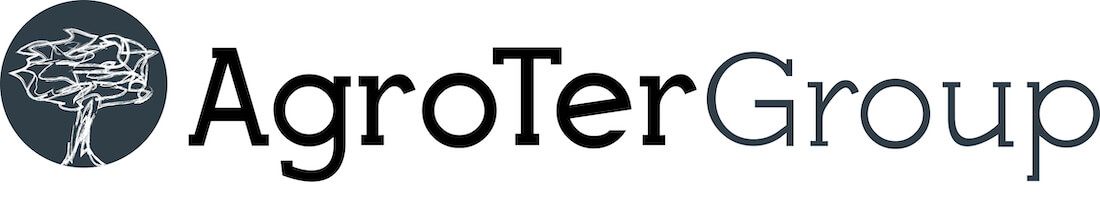Attualità
Il pero prova a rialzarsi: la ricerca accende nuove speranze
UNAPera presenta a Ferrara i primi risultati di un lavoro integrato su impianti, difesa e post-raccolta

Rimettere in piedi la pericoltura italiana, e in particolare l’Abate Fétel, sembra da anni una missione impossibile. Le criticità sono molteplici e intrecciate: gestione agronomica complessa, avversità fitopatologiche sempre più aggressive, rese penalizzate, fragilità post-raccolta. A ciò si aggiunge un dato che pesa come un macigno: la superficie coltivata a pero in Emilia-Romagna – cuore produttivo nazionale – è crollata a 10.496 ettari, quasi la metà rispetto ai 19.501 ettari del 2015. Una perdita secca di 9.005 ettari, con un trend che negli ultimi anni ha mostrato cali compresi fra l’8 e il 14% annuo. Una discesa che fotografa la crisi, ma anche la necessità di un cambio di passo ormai improcrastinabile.
Nonostante questo scenario, qualcosa si sta muovendo. E lo si è percepito chiaramente al convegno organizzato da UNAPera alla Fondazione Navarra di Ferrara, dal titolo “Ricerca e Sviluppo di nuove tecniche di gestione, difesa e post raccolta del pero”. Nel corso dell’incontro è emerso come il percorso avviato dall’AOP, nata nel 2021 e oggi forte di 25 imprese – di cui 13 OP – stia finalmente iniziando a dare risultati tangibili. L'obiettivo, come ricordato dal presidente Adriano Aldrovandi, è ambizioso: “Incrementare la competitività del settore attraverso ricerca, qualità, coordinamento commerciale e marketing, per invertire una rotta che sembrava segnata”. UNAPera gestisce la quasi totalità delle produzioni IGP dell’Emilia-Romagna e punta a rilanciare anche la superficie certificata.

Il responsabile ricerca di UNAPera Stefano Foschi ha messo a fuoco uno dei passaggi chiave: la necessità di rilanciare la rimonta degli impianti di Abate, ormai quasi azzerata, pur ritenendo la varietà ancora strategica. Le nuove cultivar, infatti, richiederanno verifiche e tempi medio-lunghi. Per fornire indicazioni chiare ai produttori, UNAPera ha elaborato un documento programmatico con la linea tecnica per impianto e prime cure colturali, frutto del lavoro congiunto tra tecnici e centri di ricerca.
Tra le raccomandazioni principali: evitare gli impianti monovarietali alternando l’Abate alla William; privilegiare portinnesti che superano i limiti del cotogno, come l’autoradicato di Conference, solo se necessario; incrementare la disponibilità irrigua; valutare con prudenza pratiche come la rottura del cotico, efficace sulla maculatura ma poco sostenibile nei terreni nel lungo periodo per i noti problemi agronomici.

Su questo fronte è arrivato anche il contributo di Alessandro Zago della Fondazione Navarra, che ha presentato i risultati delle prove sui portinnesti. L’obiettivo è individuare alternative valide al cotogno, ispirandosi ad alcune esperienze della Romagna, dove portinnesti più vigorosi hanno mostrato potenziali produttivi fra 30 e 40 t/ha. Le prove sono ancora in fase di consolidamento, ma alcuni segnali incoraggianti non mancano: l’autoradicato di Conference mostra buoni risultati, specie se allevato in vaso per superare i problemi di attecchimento. L’autoradicato di Abate appare troppo vigoroso su terreni fertili, ma potenzialmente interessante su suoli poveri. Altri portinnesti saranno messi a dimora nel 2026 per ampliare il set di valutazione.

Il quadro fitosanitario è stato approfondito da Matteo Landi (Astra Innovazione e Sviluppo), che ha illustrato le prove su corroboranti per il contenimento della psilla. Il caolino, ai dosaggi di 20–30 kg/ha, si conferma il più efficace, con riduzioni dell’ovideposizione intorno al 70%. Materiali come zeolite e talco non hanno raggiunto performance soddisfacenti. Trattandosi di prodotti facilmente dilavabili, la strategia richiede un monitoraggio attento e rinnovati interventi dopo piogge intense.
Ampio spazio è stato dedicato alla Prova Scenario 2030, che simula una difesa realistica basata sui prodotti che resteranno disponibili dopo il processo di revisione e revoca delle sostanze attive. I risultati del primo anno mostrano che la varietà Williams risulta più gestibile dell’Abate; in alcune realtà, come Ferrara, il numero di prodotti si è addirittura dimezzato. A Modena e Ravenna il numero di trattamenti è rimasto simile, ma cambia la composizione: più prodotti alternativi, più principi attivi “futuribili”. La strategia si conferma applicabile, pur richiedendo aggiustamenti in annate di forte pressione. Soprattutto, apre la strada a una linea tecnica definitiva capace di traghettare il comparto oltre il 2030.

La sezione dedicata al post-raccolta, affidata ad Alessandro Bonora (Ri.Nova), ha toccato il nodo più delicato dell’Abate Fétel: il riscaldo superficiale, una fisiopatia che compare dopo 3–4 mesi di conservazione e che finora non ha trovato soluzioni definitive. Le ricerche mostrano come la predisposizione sia legata a stress vegetativi, gestione del suolo, qualità della stagione e accumulo di antiossidanti. Da qui la necessità di selezionare le partite già in campo, distinguendo quelle idonee alla lunga conservazione. Attraverso protocolli di prelievo e bollettini settimanali è possibile stimare il rischio di riscaldo e modulare di conseguenza la conservazione, anche con l’uso di 1-MCP o atmosfera controllata. Le previsioni sperimentali mostrano una buona corrispondenza con quanto osservato in magazzino, aprendo la strada a una gestione più fine e consapevole.

Infine, Luca Casoli (Consorzio fitosanitario Modena-Reggio Emilia) ha illustrato le prospettive offerte dalle TEA – Tecniche di Evoluzione Assistita, in particolare SIGS e HIGS, basate sul silenziamento genico indotto. Si tratta di tecnologie con potenzialità significative per ridurre l’impatto di patogeni come Stemphylium vesicarium, responsabile della maculatura bruna. In attesa di un quadro normativo più chiaro, i primi risultati di laboratorio incoraggiano a proseguire.

In chiusura, Foschi ha delineato le direttrici future della ricerca: prosecuzione della Prova Scenario 2030, ampliamento dei partner scientifici, nuove valutazioni sui portinnesti, approfondimenti su fertirrigazione e post-raccolta. “C’è molto lavoro da fare – ha concluso – ma la nebbia attorno al pero comincia finalmente a diradarsi”. (lg)