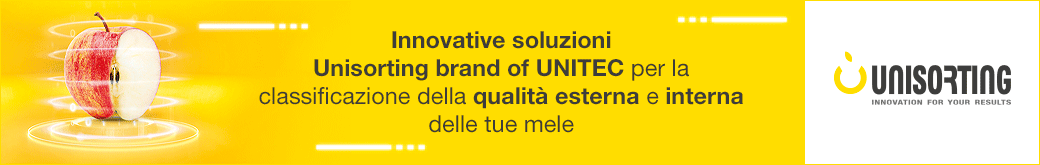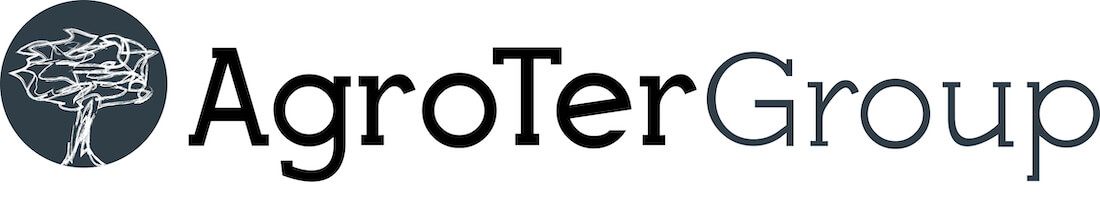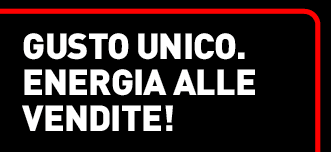Dal campo
Residui fitosanitari nel biologico: tra norme, analisi e pratica quotidiana
Nel webinar CCPB focus su contaminazioni accidentali, limiti normativi e casi pratici

Il tema dei residui fitosanitari nei prodotti biologici resta uno degli argomenti più delicati e dibattuti del settore. Non solo per gli aspetti tecnici e normativi, ma anche per le implicazioni commerciali e di fiducia lungo la filiera. Se ne è parlato nel webinar organizzato da CCPB, “Residui di prodotti fitosanitari: la lettura del dato analitico nella certificazione dei prodotti biologici”, che ha visto il contributo di tecnici e responsabili del controllo e della certificazione.
“Nel biologico la presenza di un residuo non equivale automaticamente a una non conformità,” ha sottolineato Davide Pierleoni Responsabile Vendite, Marketing e Segreteria Italia di CCPB. “Serve una lettura tecnica e normativa del dato analitico per capire l’origine e la natura di quella traccia.”

Il quadro normativo: cosa dice il DM 309/2011
La prima parte del webinar, curata da Federica Nasi, Responsabile Controllo e Certificazione area Bio di CCPB, ha fatto il punto sull’impianto normativo di riferimento.
Il DM n.309 del 13 gennaio 2011 definisce i criteri per la valutazione delle contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili in agricoltura biologica, che si applica a tutte le fasi della filiera: dai prodotti agricoli vivi ai trasformati e ai mangimi. “Per i principi attivi consentiti in biologico,” ha spiegato Nasi, “si applicano i limiti massimi di residui (LMR) del regolamento (CE) n.396/2005, gli stessi previsti per il convenzionale. Per quelli non ammessi, invece, la soglia numerica di riferimento è 0,01 mg/kg. Al di sopra di questo valore, il prodotto non può essere certificato bio, anche se la presenza è accidentale.”
Anche al di sotto di tale soglia, l’organismo di controllo deve comunque verificare che la contaminazione sia realmente accidentale e tecnicamente inevitabile. Nasi ha inoltre ricordato che, nel caso dei prodotti trasformati o compositi, la soglia deve essere adattata ai fattori di concentrazione che derivano dai processi di trasformazione o di miscelazione.

Interpretare il dato: principi attivi e fattori di processo
Il webinar ha poi affrontato la parte più tecnica dell’analisi dei residui, con gli interventi di Irene Cipollini e Chiara De Angelis di CCPB
Cipollini ha evidenziato come nella lettura dei risultati analitici sia essenziale considerare i “fattori rallentanti” e la natura chimica dei principi attivi, che possono influenzare la rilevabilità dei residui. De Angelis ha approfondito invece il concetto di fattore di processo, ovvero il rapporto tra la concentrazione del residuo nel prodotto trasformato e quella nel prodotto grezzo, come indicato nell’Allegato I del Regolamento (CE) n. 396/2005 e nel documento SANTE/10704/2021 Rev 1. “Un valore analitico va sempre interpretato nel suo contesto,” ha spiegato De Angelis. “Bisogna tener conto del percorso del prodotto e delle trasformazioni subite: solo così il dato assume un significato reale ai fini della certificazione.”
Falsi positivi e il caso clorato
Un altro tema chiave, affrontato da Paolo Pucci del laboratorio Tentamus Agriparadigma, è stato quello dei falsi positivi, ossia dei residui rilevati che non derivano da trattamenti volontari. “Un esempio classico,” ha spiegato Pucci, “è la presenza di ditiocarbammati nella rucola: si tratta spesso di contaminazioni ambientali o legate a processi tecnici, non all’uso diretto di fitofarmaci.”
Particolare attenzione è stata dedicata al clorato, sostanza non autorizzata come prodotto fitosanitario ma che può comparire come sottoprodotto dell’uso di disinfettanti a base di cloro nell’acqua potabile o nei processi di lavaggio e trasformazione. Il Regolamento (UE) 2020/749 stabilisce per il clorato un LMR generale di 0,01 mg/kg, applicabile a tutte le derrate alimentari. “Nel caso del clorato,” ha chiarito Pucci, “non si tratta di un residuo da fitofarmaco ma di un effetto collaterale dei processi di sanificazione. È importante applicare il principio ALARA (As Low As Reasonably Achievable), cioè, mantenere i livelli tanto bassi quanto ragionevolmente ottenibili.”
Dal confronto è emersa una linea comune: garantire il rispetto della normativa, ma con un approccio tecnico e proporzionato alle reali condizioni produttive. Un messaggio chiaro per tutta la filiera: il dato analitico non è un numero da interpretare in modo meccanico, ma il punto di partenza per una valutazione approfondita che tiene insieme scienza, normativa e pratica agricola.